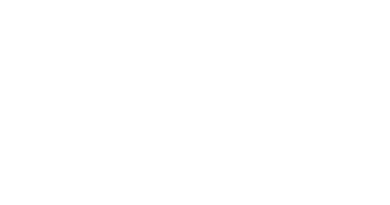Recensione di Elvis: il film biografico ridicolo e sublime di Baz Luhrmann
La prima volta che diamo una buona occhiata al personaggio del titolo dello spettacolare Wikipedia contenente caffeina di Baz Luhrmann, Elvis , sta uscendo dall’ombra e su un palco in Louisiana, pronto a esibirsi davanti a una folla totalmente ignara del fatto che stanno per assistere al incoronazione del futuro re del rock ‘n’ roll. Vestito di rosa dalle spalle alle caviglie, il rubacuori diciannovenne esita e il pubblico, sentendo l’odore del sangue, lo disturba. Ma poi Elvis Presley (Austin Butler) si lancia nelle note di apertura di quello che diventerà il suo primo successo nazionale, Baby, Let’s Play House , e mentre suona la cintura e strimpella, il suo corpo barcolla e si spinge. Si muove come colpito da un fulmine e la corrente elettrica attraversa l’intero locale, svegliando di soprassalto le giovani donne presenti, la loro libido immediatamente accesa dai suoi suggestivi giri di predicatore campestre.
Troppi film biografici da contare includono un momento in cui è nata una star come questo. Ma Luhrmann, l’irrefrenabile ghiottone di imbonitori di carnevale dietro Moulin Rouge e Il grande Gatsby , mette in scena la sequenza con uno stile infernale che la spinge oltre i cliché, alla parodia, e poi ancora oltre, a un impeto di isteria da cartone animato. Un fulmine di chitarra elettrica impreziosisce la canzone, sacrificando il realismo storico sull’altare della gloria del rock da arena e cross-era. E le ragazze non si limitano a urlare. Esplodono in una specie di estasi involontaria, come se fossero posseduti dallo spirito del crudo magnetismo animale di Presley. Superando una convenzione musicale-drammatica di serie, Luhrmann raggiunge le vette del mito: l’ascesa di un dio della radio come rivoluzione sessuale individuale, liberando tutta la frustrazione repressa della gioventù americana e dimezzando la storia nel processo.
Quel tipo di energia domina Elvis . Sulla carta, il film è puro campione biografico, che collega 25 anni di punti salienti nella vita e nella carriera dell’artista solista più venduto di tutti i tempi. Eppure Luhrmann non è un contabile o uno storico di fama mondiale. Fin dall’inizio, taglia il film biografico musicale in una follia, caricandone i ritmi familiari, affrontando i suoi obblighi attraverso un collage di album di titoli, inquadrature della folla e azione a schermo diviso. Elvis è strutturato come una bobina sfrigolante di quasi tre ore. Non ha tanto scene quanto suite. Si muove .

L’approccio overdrive di MTV di Luhrmann potrebbe essere tanto strategico quanto patologico. Elvis può solo coprire tutto il terreno che deve coprire a velocità di curvatura, raccontando elementi della sua storia vera lunga decenni attraverso implicazioni e abbreviazioni. L’ascesa alla fama. La battaglia contro i rimproveri morali scandalizzati. Il successivo contraccolpo all’Elvis compromesso e amico del pastore, che è fondamentalmente il momento inverso del Dylan-goes-electric del cantante. Elvis corre attraverso tutto questo. Nel frattempo, la carriera del re a Hollywood è relegata in un unico ed elegante montaggio Technicolor. Il suo servizio all’estero è completamente omesso.
Nella misura in cui questa rivista massimalista di Graceland ha un centro drammatico, è la relazione inizialmente simbiotica e sempre più parassitaria tra Elvis e il suo famigerato manager sfruttatore, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks). La sceneggiatura, un evidente mosaico di bozze di Luhrmann e altri, inizia la storia con Parker che sente l’odore della superstar in una fase embrionale. (La sua scoperta che la voce da un milione di dollari alla radio appartiene a un uomo bianco è accompagnata da un esilarante zoom sul viso di Hanks, mascherato da un naso finto e animato dallo shock e dalla brama di opportunità). Parker finisce per sedurre Elvis in un contratto al quartiere fieristico, emettendo il suo discorso faustiano in cima a una ruota panoramica. Tra le altre cose, questa è una storia perduta di innocenza: un montaggio di molti tagli incrociati di Elvis che perde la verginità con scatti di sua madre che si agita.
Ciò che Parker ha calcolato era l’immenso potenziale commerciale nell’avvoltoio culturale di Presley, il modo in cui riconfezionava per un pubblico bianco il suono e le mosse degli artisti neri che ascoltava in gioventù. Elvis mette naturalmente in primo piano quell’aspetto della storia da ricchi a ricchi del musicista, persino inserendolo nei tropi Walk Hard che dà energia: mentre il re si pavoneggia sul palco, Luhrmann taglia il filmato di un preadolescente Presley che spia un’esibizione da cortile di Arthur ” Big Boy” Crudup , un vero contendente per il titolo di padre del rock ‘n’ roll. Più tardi, una sequenza avvincente assemblata ritrae Elvis che cammina letteralmente tra l’America bianca e quella nera, a casa sul prato di una piantagione e in Beale Street. Il film coglie la vera minaccia che i conservatori hanno visto in Elvis: la loro paura non solo della sua sessualità esagerata, ma anche della cultura nera su cui stava capitalizzando in modo redditizio.

Parker racconta il film, insistendo ripetutamente sul fatto che l’eventuale declino e morte di Elvis sono stati un prodotto della sua instancabile devozione alla realizzazione di uno spettacolo, anche se ciò che vediamo attribuisce la colpa più esattamente alla guida connivente e controllante del suo manager. Questo è un punto di vista potenzialmente ingegnoso, per inquadrare la storia attorno alle deviazioni inaffidabili del suo cattivo. Hanks, però, è insolitamente, quasi straordinariamente atroce nel ruolo. Il casting ha senso in teoria, trasformando l’essenziale decenza paterna della nostra star di Hollywood più affidabile in una tattica di manipolazione. Ma anche un film così oltraggiosamente accresciuto non può supportare l’assurdità da grasso della performance di Hanks, che combina il macabro trucco di Austin Powers con un accento nordico davvero bizzarro e vaudeville che suona quasi per niente come il vero uomo parlava davvero. Hanks è semplicemente troppo ridicolo per essere preso sul serio qui, e le sue scene inclinano il film in modo precario vicino alla commedia di sketch.
Butler, che suda copiosamente attraverso un guardaroba rotante di famosi abiti alla moda, se la cava meglio come The King. È una performance stampa-la-leggenda, tutta spavalda e atteggiamenti da pinup boy, con molto più attitudine – e sex appeal – della psicologia. Ma questo si addice a un film biografico con un maggiore interesse per la leggenda sismica di Elvis rispetto a chi fosse veramente sotto tutto il carisma della supernova e le tute bianche con paillettes. Che Butler a volte assomigli non tanto a Elvis quanto a un numero qualsiasi di atti flash-in-the-pan debitori allo stile dell’artista rafforza solo la concezione implicita di Luhrmann della storia del rock come un gioco del telefono, distorcendo la voce originale con ogni nuova consegna o generazione.
Elvis è ovunque, afferma il film, un’idea che comunica attraverso una colonna sonora che rallenta e trasmette grandi successi come “Fools Rush In”, remixandoli in una serie di inni spettrali che riecheggiano dalla coscienza della cultura pop. Il regista di Moulin Rouge , ovviamente, ha anche rifornito il suo jukebox di anacronistiche gocce d’ago, alternando l’hip-hop con le moderne cover di The King per sottolineare come l’originale atto di appropriazione di Elvis sia solo un capitolo nel tortuoso percorso della musica popolare americana. È un collegamento più riuscito rispetto ai numerosi tentativi del film di collocare Elvis sullo sfondo tumultuoso delle ultime notizie di metà secolo. Forse Hanks è davvero in giro per rafforzare le associazioni di Forrest Gump su una sceneggiatura che periodicamente va alla deriva su un televisore e sugli omicidi riportati su di esso.
Dopo oltre due ore di incessante riassunto del supercut, il film rallenta e si esaurisce. Una componente essenziale della storia di Elvis è la sua parte in rovina: quegli ultimi ignobili anni a Las Vegas, quando l’uomo ha finito le rimonte, si è fatto prendere le pillole ed è diventato prigioniero della sua residenza al casinò e della morsa che Parker aveva sul suo portafoglio. È qui che deve andare la trama, ma nel drammatizzare diligentemente l’ultimo atto di questa vita, Luhrmann risucchia tutto l’entusiasmo dell’uomo selvaggio dal suo materiale. L’atto finale è un faticoso crollo in una conclusione tragicamente scontata, sormontata da filmati d’archivio obbligatori.
Dove prende vita, prima ancora, è sul palco. Qui, l’appassionante approssimazione di un luminare da festa in costume di Butler si fonde con l’irrequietezza di Luhrmann per produrre qualcosa come un monumento alla mitologia di Elvis. Il film se la cava, per gran parte del suo tempo di esecuzione gonfio, sulla fantasticheria estatica e temeraria della sua spettacolarità: il modo in cui incanala la presenza scenica calpestabile del re attraverso una scarica senza fiato di immagini e suoni, cercando di trasportare il pubblico nello stesso frenesia che Elvis ha ispirato nella sua stessa vita. Come, scommette Luhrmann, possiamo misurare la vita di questa figura monumentale e destabilizzante attraverso qualcosa di meno che una stravaganza da capogiro? Qua e là, l’eccesso della sua vista ripaga, passando da estenuante a esilarante.
Elvis debutterà nelle sale di tutto il mondo venerdì 24 giugno . Per ulteriori recensioni e scritti di AA Dowd, visita la sua pagina dell’autore .